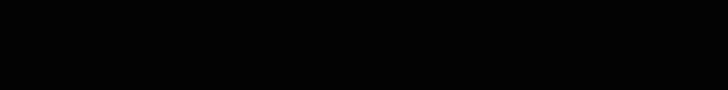A Ferrara si va “Fortissimo”

Matteo Bianchi ci racconta la sua “Penna”
2 DICEMBRE
«I don’t want to be the one / left in there, left in there»… laggiù, in una cittadina tra i campi, sul cuscino di lui lei aveva sistemato una mattina il suo pigiama, prima di andare al lavoro. Si sa quanto i pigiami siano morbidi. E magari sono quello che portiamo addosso di più sincero. Spontanei, a volte scontati. Quello che basterebbe per svegliarsi bene il primo gennaio. Il suo aveva un biscotto enorme, tante stelline e tante piccole lune su un cielo blu. E lui che con gli occhi la seguiva da mesi sul finire del turno, in mezzo alla folla degli acquisti, sapeva che ci sono cieli e notti in giro che riempirebbero una casa. Più delle luci di Natale. Notti sfogliate solo nei racconti che l’avrebbero scaldato più del solito cappotto grigio. Quello da battaglia, appeso vicino all’entrata. Di solito lei dormiva sul fianco destro, lievemente raccolta, con le braccia al petto; perciò, quando spegnevano la luce al secondo piano in una stanza tra le tante, lui le prendeva le mani e la stringeva a sé. In due si vede anche al buio, e il buio stesso si fa inconsistente. Talvolta si svegliava per assicurarsi che lei non avesse freddo, le baciava i capelli che si erano sciolti sul cuscino e tornava ad appoggiare il viso sulla sua schiena, sperando di avere altri dieci minuti a disposizione, sebbene del tempo non gli importasse più granché.

Il libro si intitola Fortissimo (Minerva), comprende un mezzo piano e si apre con dei versi degli Anthony and the Johnsons. Quali e quante musiche ci sono in questo libro?
«Il testo di Hope there’s someone si sovrapponeva a quello che sentivo per la persona di fianco a me in quel momento. La musica è la prova di una coincidenza che diventa emozione. Anche il tono e il timbro vocale erano adatti alla circostanza. Fortissimo e Mezzo piano hanno sia una connotazione fisica di spazio, legata alla percezione della realtà circostante, sia una temporale: il mezzo piano è il mezzanino di ogni condominio che consente incontri momentanei, in cui ci si dice tutto con uno sguardo. Esiste una sfumatura musicale che lega i due titoli: sono entrambi indicazioni dinamiche dell’intensità sonora e, astraendo, offrono la possibilità di dare volume alle conseguenze delle nostre azioni».
Se dovessi scegliere una (o più d’una) canzone da ascoltare in sottofondo, leggendo le tue poesie, quale sarebbe?
«Mi hanno accompagnato nella stesura l’intero Bon Iver, Bon Iver, Solitude di Ryuchi Sakamoto, Odradek di Alva Noto, proprio per affrontare il buio. È stata la reazione visionaria di questi artisti, ognuno con il proprio stile, a convincermi; il modo con cui si sono opposti all’incombenza del passato sul presente. D’altronde “il sogno è l’infinita ombra del vero”, scriveva Pascoli».
Secondo te, poesia e musica mantengono ancora oggi il legame indissolubile che hanno fin dalle origini?
«Decisamente. La prima parte del libro è una prosa poetica, vale a dire una prosa costruita mediante figure retoriche, prevalentemente di suono. Uso assonanze, allitterazioni e rime in quantità per sostenere quello che di fatto è un flusso di coscienza. Un monologo interiore che asseconda i miei stati d’animo. È il riflesso di quello che ho provato, e la musica mi è fondamentale per tenere insieme il discorso. Dove non c’è logica e razionalità, e nella poesia non c’è, la musicalità è un medium: dà alla parola lo slancio necessario per arrivare all’orecchio del lettore, non solo alla sua mente. Non applico una struttura metrica tradizionale abbastanza solida o lavorata, sono andato a orecchio».
E il mondo della musica e quello della letteratura trovano ancora qualche connessione?
«Sono in realtà molto scoraggiato, mi demotiva parecchio il panorama attuale, perché il punto di collisione più forte era quello cantautoriale, anello di congiunzione tra testo poetico e musicale. Siamo circondati da prove scadenti, non trovo contemporanei viventi degni di nota. Forse solo Nicolò Fabi riesce a tenere il punto, e, quando è in forma, Samuele Bersani, poiché dimostra un grande rispetto nei confronti della lingua, questo per quanto riguarda i più giovani. Guccini, Branduardi e Vecchioni sono indimenticabili soprattutto per le prime prove; Battiato e Tenco, ovviamente, e pure Gino Paoli agli esordi. Ma la cosiddetta “scuola genovese” in toto, conquistata dalla passione di De André: “Sono evidentemente fortunato – annotava sotto le ciglia – soprattutto quando riesco a trasformare il disagio in qualcosa di bello e magari anche di utile, non necessariamente di memorabile”.
Un altro filone interessante è quello che unisce il rap al poetry slam, la poesia d’occasione incanalata su un tema a richiesta. Io non sono vicino a quel metodo di scrittura: nel poetry slam la forma si impone troppo sul contenuto rischiando di impoverirlo, non solo di storpiarlo. Davanti a un impoverimento cambierei approccio, per questo non l’ho mai concepito, anche perché scimmiotta un’urgenza, è un volersi dare un tono d’emergenza che di fatto non corrisponde alla realtà. Non c’è più la ricerca di equilibrio».
I temi portanti del libro sono l’amore, il tempo, la quotidianità. Qual è il filo rosso che tiene tutto insieme?
«Il filo rosso della raccolta è la necessità di innamorarsi, perché spesso, anche se non sempre, innamorarsi o riuscire a innamorarsi ancora rende liberi. Che poi sia una libertà illusoria ed effimera, che non può fare i conti con la realtà, è vero, ma l’esigenza rimane. Se vogliamo tracciare un parallelo musicale, ciò che lega i miei testi è l’innamoramento che dà il la a un sentimento amoroso, proprio come la prima nota avvia un brano».
a cura di
Irene Lodi