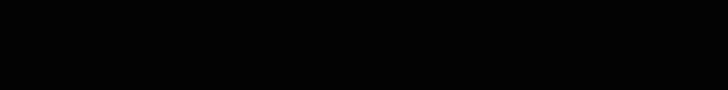“Invelle” di Simone Massi: l’opera che custodisce il ricordo

La manualità contadina e la fatica dei fotogrammi si uniscono in un unico percorso per raccontare questa storia in un luogo che non è, o comunque non c’è perché è ovunque. “Dove sei stato per tutto questo tempo?” “Invelle” – che in dialetto marchigiano significa “in nessun posto” – chiude con solenne fatalismo le tre storie raccontate dal regista Simone Massi, esordiente nel mondo dei lungometraggi con una storia cruda e reale.
La prerogativa dell’autore è di proporre al pubblico una storia scomoda, sia stilisticamente sia concettualmente parlando. Simone Massi si defila volutamente insieme ai suoi protagonisti da una Guerra con la g maiuscola – la guerra dei protagonisti, dei soldati e delle città – per parlare delle vite di contorno, toccate temporalmente dai grandi avvenimenti italiani (andanti dalle due Guerre Mondiali agli anni di piombo), e per mostrarci quanto la vita delle persone comuni sia cambiata, a seconda delle scelte di altri e del tempo storico in cui si vive.
“Invelle”
Nel 1918 Zelinda è una bambina contadina con la madre in cielo e il padre in guerra, a cui tocca smettere l’infanzia e indossare la casa, i fratelli, la stalla e le bestie.
Un giorno torna ad avere una famiglia. Alla fiera del paese la bambina si stringe al babbo e spalanca gli occhi per far posto a tutte le cose che le si parano davanti. Vere o immaginate che siano, ormai Zelinda quelle cose le ha viste e si è fatta una sua idea di come gira il mondo.
E questo gira così velocemente che di colpo la sua storia diventa quella di un’altra. Nel 1943 Assunta è una bambina contadina che sta in equilibrio su una gamba, con la testa guarda il cielo e tiene il piede in guerra (un’altra!). Ma appena ne ha la possibilità, si cuce un vestito colorato, fa un saltello e… hop! La guerra era tutto uno scherzo, o comunque adesso non c’è più.
Quest’ultima (forse!) si è dissolta, e con essa scompare un mondo intero: un salto più grande di quel che sembrava. Nel 1978 Icaro è un bambino contadino che gira in tondo attorno al niente. È stato sognato tanti anni prima e deve realizzare quello che non è stato possibile a sua madre e a sua nonna. E a chi è venuto prima di loro.
I protagonisti
Zelinda diviene da subito ciò che la vita la rende: un’orfana che sarà salvata grazie all’amore di chi può permettersi di sostentare un altro essere umano, dall’altruismo e dalla comunità.
Potrà permettersi di continuare ad esistere e camminare lungo un percorso a funzione limitata già prestabilito dalla società, dove diventerà moglie, casalinga e madre di Assunta.
Non c’è spazio per i desideri ma solo per la praticità. La vita che conosce è una e rimarrà fedele ad essa, senza analizzare ulteriori possibilità.
Zelinda è portavoce di una passività socialmente accettabile, propria di un’epoca disarmante che non lascia spazio al dolore ma nemmeno alla vita.
Ci troviamo poi in un altro periodo storico, catapultati – oniricamente parlando – in avanti, dove Assunta custodisce dentro sé una fantasia meravigliosa e giusta, ma non è altri che l’ennesima protagonista di una storia già vissuta, che si ripete perché “funziona”: il suo basso profilo diventa una necessità e non un peso.
Come ultimo step incontriamo Icaro, un bambino curioso che vive nel periodo di deruralizzazione in favore del progresso edilizio, sradicato da una vita che conosce e posizionato altrove, per realizzarsi in modi a lui sconosciuti: ciò che è certo è che rimane intenzionato a conoscere il mare, in un’epoca che sta cambiando.
Analisi del film
Stilisticamente parlando, il film si compone di 40.000 fotogrammi, la cui tecnica è costituita dall’utilizzo di pastelli ad olio graffiati con strumenti incisori. I colori che si insinuano nel racconto sono pochissimi, andando ad insistere sul realismo e a confinare la poesia a pochi attimi. È una chiara scelta e uno schieramento nei confronti di chi vive come può e di chi non può lasciar trasparire le emozioni, per evitare di venire travolto e risucchiato dall’incertezza.
Lo spettatore è scomodo, sofferente, si interroga su ciò che è presentato al suo cospetto. Se ciò che vede sia realtà o sogno, o – più accuratamente parlando – incubo. Un incubo che c’è stato davvero, perché siamo nella mente di chi ha vissuto il periodo storico in quel modo senza porsi domande.

Vedere la pellicola è stato come trovarsi al cospetto di nonni che tramandano esperienze tramite i loro racconti. Le similitudini con i sogni sono innumerevoli se ci pensiamo bene, le storie seguono il flusso dei pensieri ed hanno priorità diverse a seconda della soggettività di chi li espone. Possono non presentare un inizio o una fine netti, o assumere forme diverse in qualsiasi momento. Ciò che è certo è che, nonostante la loro forma, sono ricordi e sono loro ad essere i protagonisti.
Non parleranno mai come libri di storia impettiti e lineari, ma si racconteranno per come sono. Io ho rincontrato i miei cari in Invelle: negli oggetti posti in background mentre la storia si districa, nei suoni di vita quotidiana, mentre le giornate si svolgono lente.
Come in una fotografia.
Dove vanno le memorie?
Non è vero che non vanno in nessun posto.
Invelle è un racconto di vita comune, adatto a chi le domande ha voglia di porsele e a chi ha una mente aperta per capire che le persone sono fatte in base a come reagiscono a ciò che succede loro.
Il mio voto al film
Quello che penso del film si può racchiudere in un 8 carico di emozione. Guardare Invelle è stato come vivere per qualche ora una relazione familiare, correlata dal ventaglio di sensazioni tipico che la rendono vera: impazienza, emancipazione, malinconia e affetto.
Non ho visto una famiglia, ho visto la mia. Come quando gusti un piatto stellato e rivivi odori e sapori che ti ricordano casa, così la descrizione silenziosa della vita di quel tempo con gli utensili, i gesti e l’amore nascosto in ogni cosa è stato per me un album di ricordi.
a cura di
Michela Besacchi
Seguici anche su Instagram!