Un saggio su come liberarsi dal giudizio degli altri ispirato alle teorie di Adolf Adler
Un giovane e un anziano filosofo si incontrano per cinque notti per discutere della ricerca della felicità. Ne nasce un libro, Il coraggio di non piacere, scritto da Ichiro Kishimi e Fumitake Koga. L’opera, uscita nel 2019 per DeAgostini, è diventata un best seller a livello mondiale.
Ogni capitolo è dedicato ad una notte in cui viene affrontato un determinato argomento. Le conseguenze del passato sulla nostra psiche, i traumi, le relazioni interpersonali, il senso d’inferiorità, l’abitudine di paragonarsi agli altri e la continua ricerca dell’approvazione altrui.
Le teorie di Adler
Il filosofo illustra al giovane le teorie di Alfred Adler, psichiatra austriaco, precursore della “psicologia individuale”. Questa scuola di pensiero, innovativa per l’epoca, si basa sulla teleologia, disciplina che studia lo scopo di un fenomeno anziché la causa. La tesi di Adler è in contrapposizione con il metodo di Freud, la cui psicologia è basata sull’eziologia, lo studio delle cause di un dato fenomeno. Per l’eziologia ad esempio, la condizione presente di un dato individuo è determinata dagli eventi vissuti nel suo passato.
Secondo Freud, se un individuo ha subito un forte trauma da bambino, questo lo condizionerà nell’età adulta a tal punto da renderlo infelice. Secondo Adler invece, il trauma può senz’altro avere un forte influsso nella vita dell’individuo, ma non gli preclude in alcun modo di trovare la serenità in età adulta.
In altre parole, il trauma non determina per forza di cose il nostro destino, ma ciò che conta è come si decide di reagire ad esso.
“Nessuna esperienza è, di per sé, causa del nostro successo o fallimento. Non soffriamo per lo shock delle esperienze – per il cosiddetto trauma -, bensì ne traiamo ciò che serve ai nostri scopi. Non siamo determinati dalle nostre esperienze, ma il significato che attribuiamo loro è autodeterminante. La vita è qualcosa che qualcuno ti dà, ma la scegli da solo, sei tu a decidere come vivere.”
Un altro assunto spiegato nel libro è quello secondo il quale i nostri problemi derivino tutti dalle relazioni interpersonali. Secondo Adler, spiega sempre il filosofo, se non avessimo nessuno con il quale paragonarci, non soffriremmo il senso di inferiorità che continuamente ci attanaglia.
Il termine “senso di inferiorità”, nell’accezione in cui lo conosciamo oggi, è stato coniato da Adler. La parola deriva dal tedesco Minderwertigkeitsgefuhl, cioè la sensazione (Gefuhl) di avere meno (minder) valore (Wert).
Noi ci sentiamo inferiori perché ci auto svalutiamo, ci diamo poco valore, e quindi si tratta di un giudizio soggettivo. Per spiegare questa teoria, il filosofo attinge alla sua vita personale: egli quando era giovane si deprimeva perché era basso di statura e ne parlò con un amico. Quest’ultimo gli rispose che erano tutte stupidaggini e che le sue sfortune non derivavano da questo fattore. Insomma, se fosse stato più alto non sarebbe cambiato nulla. Di contro gli fece notare i suoi pregi, come la sua capacità di tranquillizzare le persone. Gli fece capire che poteva usare questa sua qualità per fare del bene. La percezione di sé stesso cambiò e il filosofo usò queste caratteristiche positive per farsi apprezzare dagli altri e aumentare la propria autostima.

Adler parla anche di senso di superiorità e lo definisce in questo modo: gli individui che si credono superiori agli altri, in realtà soffrono di un profondo senso di inferiorità. L’individuo pieno di sé non riesce a colmare il vuoto derivante dalle sue insicurezze perché non ha il coraggio di cambiare sé stesso. Quindi si inventa un’ipotetica superiorità per giustificare il fatto che non riesce a migliorarsi.
“Coloro che si vantano spudoratamente di cose non hanno, in realtà, alcuna fiducia in sé stessi. Anzi, chi si vanta lo fa proprio per un senso d’inferiorità.”
Un altro punto su cui si sofferma il filosofo è il concetto che la vita non è una competizione.
Sebbene Adler riconosca che il desiderio di essere superiori agli altri sia un desiderio universale, bisognerebbe aspirare a migliorarsi e non sentirsi in competezione con gli altri.
“Benché la distanza percorsa e la velocità siano diverse, tutti camminano nello stesso spazio piatto. L’aspirazione alla superiorità è la mentalità che ci induce a fare un solo passo avanti con le nostre gambe, non quella che, rendendoci competitivi, ci spinge a voler surclassare gli altri… non importa se la persona cerca di camminare davanti o dietro gli altri. È come se ci spostassimo attraverso uno spazio piatto, senza asse verticale. Non camminiamo per competere con qualcuno. Il valore è racchiuso nel tentativo di superare ciò che si è ora.”
Infine, il punto focale del libro è il concetto di vivere senza ricercare l’approvazione altrui. Secondo Adler ognuno di noi dovrebbe vivere perseguendo i propri desideri, senza preoccuparsi di soddisfare le aspettative altrui. Questo obiettivo si può raggiungere rispettando la suddivisione dei compiti che ognuno di noi ha. Il bambino ha il compito di studiare e i genitori quello di educare. In poche parole, loro possono guidarlo nella comprensione che quello è il suo compito e fornirgli aiuto se ne ha bisogno. I genitori non possono imporre al bambino di studiare perché il suo rendimento scolastico è responsabilità sua. Questo spiegherebbe perché in tante famiglie, quando un genitore si impone troppo sui figli, ottiene l’effetto contrario. Per Adler ognuno ha il proprio compito e non bisogna interferire con quelli degli altri.
Di fronte alle continue pressioni degli altri e della società intera, Adler sostiene l’importanza di vivere seguendo i propri desideri, senza ricercare l’approvazione altrui. Le aspettative altrui sono compito loro e non nostro.
“Se vivi in modo da soddisfare le aspettative altrui e affidi la tua vita agli altri, menti a te stesso ed estendi la menzogna a coloro che ti circondano.”
Inoltre la vera libertà, secondo Adler, sarebbe riuscire a vivere senza l’approvazione altrui. La libertà di vivere come si vuole implica, per forza di cose, il non essere approvati dagli altri.
“C’è un prezzo da pagare per esercitare la propria libertà e, nelle relazioni interpersonali, coincide con la disapprovazione altrui […] Occorre andare avanti senza temere la possibilità di essere disapprovati. Ipotizza che io mi trovi di fronte a due alternative – una vita in cui piaccio a tutti e una vita in cui ricevo la disapprovazione di alcuni – e che mi venga chiesto di scegliere. Opterei per la seconda possibilità senza la minima esitazione. Prima di preoccuparmi del giudizio altrui, voglio seguire il mio essere fino in fondo, cioè voglio vivere libero […] Il coraggio di essere felici sottintende anche il coraggio di essere disapprovati. Quando conquisti quel coraggio, le tue relazioni interpersonali si alleggeriscono all’istante.”
Un’opera che ci fa rivalutare le nostre credenze
Il saggio di Kishimi e Koga ci spiazza, come fa il filosofo col giovane allievo, scettico nei confronti delle sue teorie. Ci aiuta a guardarci dentro e a sradicare certe nostre convinzioni: perché ricerchiamo sempre l’approvazione altrui, anche se gli altri non ci piacciono? Perché ci sforziamo di soddisfare le loro aspettative, sebbene queste non ci rendano felici? Perché ci sentiamo inferiori agli altri?
Con la calma e il consueto pragmatismo delle culture orientali il saggio ci aiuta a vivere una vita più autentica e conforme alle nostre reali esigenze. Per vivere una vita che sia realmente nostra e che non sia scelta da altri. Per capire da dove deriva il nostro senso d’inferiorità e come trovare il coraggio di cambiare.
Ichiro Kishimi, laureato in Filosofia con una specializzazione in Filosofia occidentale, è psicologo e counselor e vive a Kyoto. Fumitake Koga ha scritto parecchi manuali di business e saggi e dopo aver abbracciato la scuola di pensiero di Ichiro Kishimi, lo va a trovare spesso a Kyoto.
a cura di
Silvia Ruffaldi
Seguici anche su Instagram!


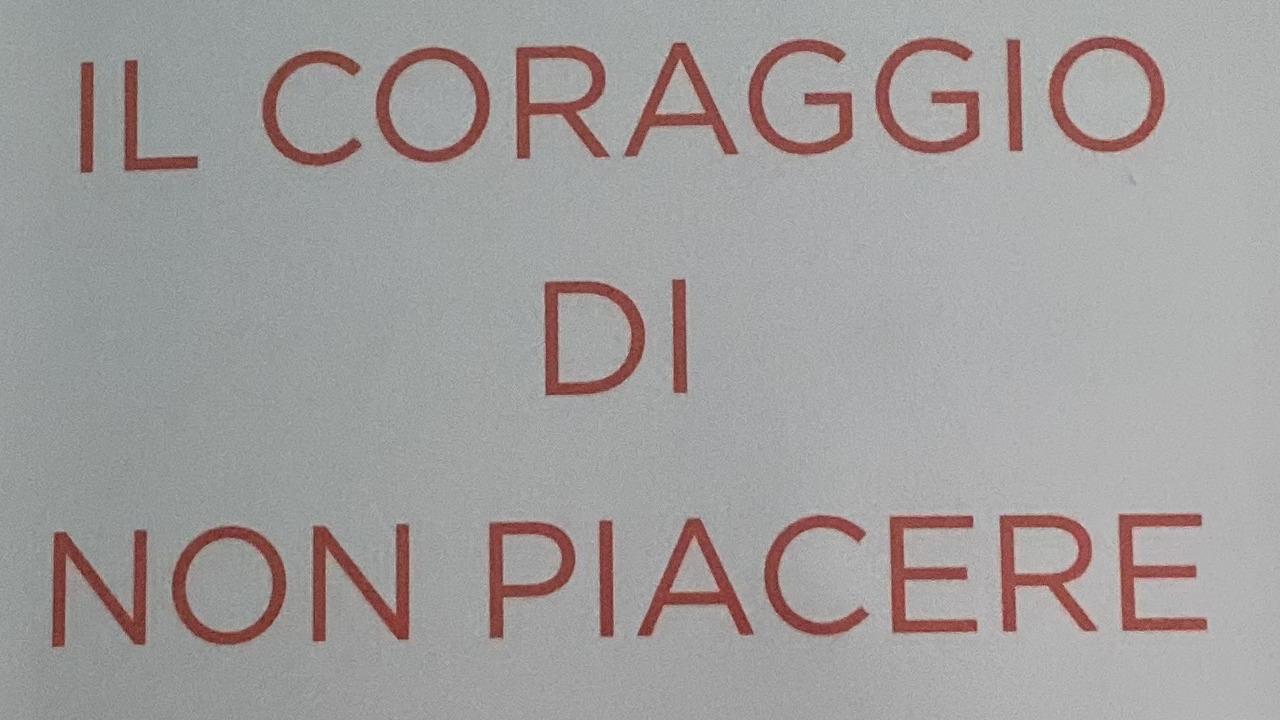


[…] ANCHE – “Il coraggio di non piacere” di Ichiro Kishimi e Fumitake KogaLEGGI ANCHE – Motta – Rebel House, Pergola – 23 febbraio […]